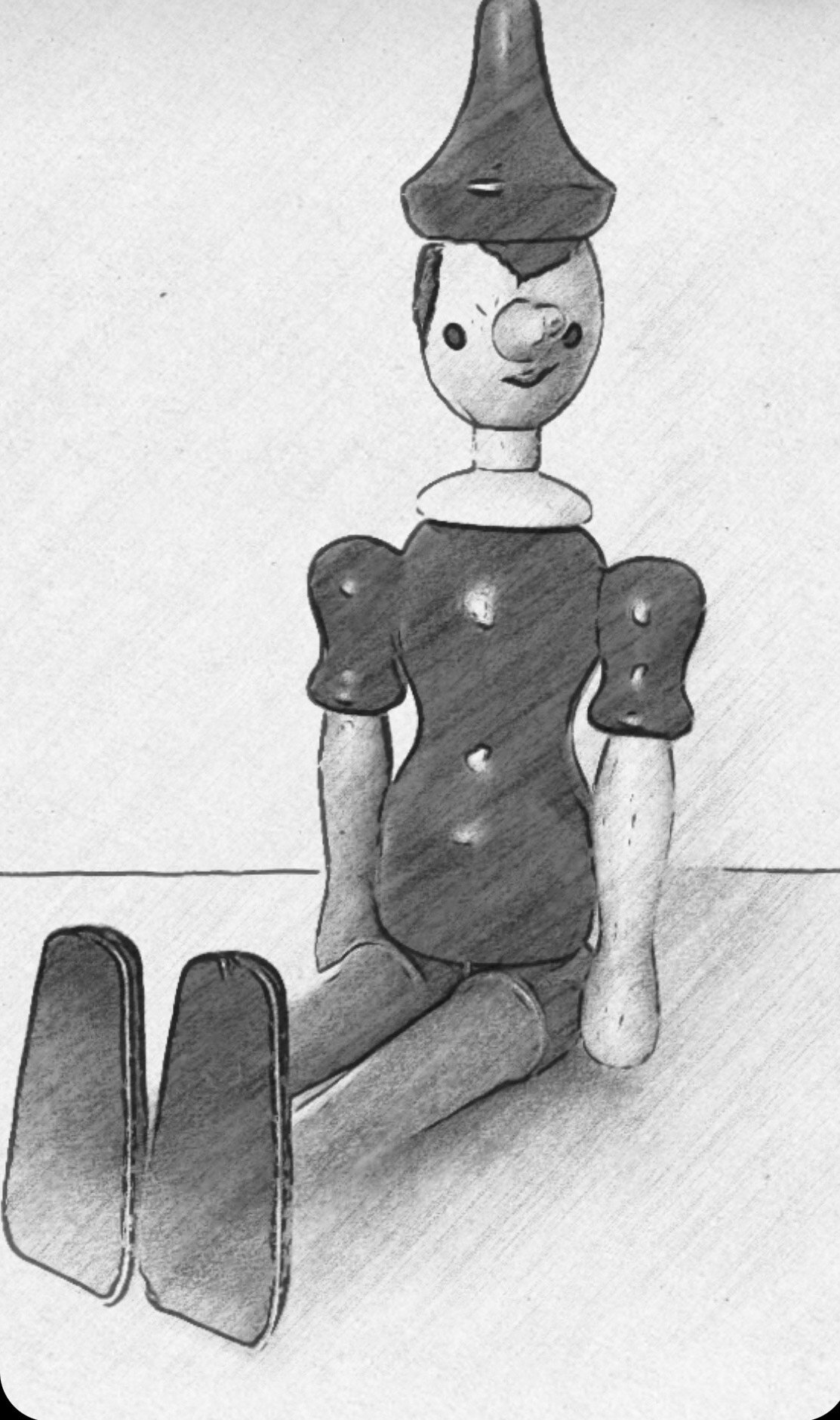PINOCCHIO IN CARNE ED OSSA by Giovanni Ceccanti
Alexander Calder “Disco Rosso, punti bianchi su nero”
37.
Che strano fu per Pinocchio vedere il suo vecchio corpo da burattino bruciare e ardere nel caminetto, dove Geppetto lo aveva messo come un ceppo propiziatorio per la nuova vita che aveva davanti.
Stavolta veder bruciare i suoi vecchi piedacci duri non lo sconvolse affatto. Anzi, era così felice di averne di nuovi che se li toccava sempre, pieno di meraviglia. Erano così lisci! Poteva accarezzarli dolcemente e, risalendo su per lo stinco, arrivare al ginocchio senza prendersi una sola scheggia o saltare su un nodo. Poteva restare dei minuti a guardarsi le dita dei piedi o delle mani soffermandosi sulla minuzia dei particolari, sulla lucentezza delle unghie o perdendosi nel labirinto delle impronte digitali.
Quel corpo chiaro e soffice lo entusiasmava. Non odorava più di olio di lino e vernice ma di talco e sapone.
E ancora: le vene violette delle cosce magre, la peluria fina e bionda sulle braccia, per tacere della chioma folta di capelli corvini dentro cui passava soddisfatto le mani. Il cuore pulsante che gli rimbombava in petto e che scandiva il tempo come il cucù della cucina. Non bastava questo miracolo per trascorrere le ore?
Dopo aver subito la sbandata per il suo nuovo corpo, Pinocchio sentì una vertigine per la sua caducità.
«Ero legno duro – disse quasi strozzando un grido – ora sono morbida carne! Debbo forse temere la stagionatura? Che genere di corruzione mi conviene immaginare?»
Geppetto non sapeva cosa rispondergli e un giorno, sul far della sera, dovette intervenire la fatina per assicurarsi che Pinocchio, il nuovo Pinocchio in carne e ossa, non avesse frainteso quanto da poco guadagnato.
«È l’anima – gli spiegò paziente, con la sua voce di cristallo – che ti ho dato in dote. Un bambino vero è un bambino con un’anima tutta sua. Un’anima linda e pinta. Non ti fissare perciò, figliolo mio, sul tuo nuovo corpo di carne e ossa. Non temerne la stagionatura. Abbi fede, piuttosto, nell’eternità della tua anima. Concentrati su di essa, e fallo bene: che sia forte come una fortezza e alta come una torre».
38.
Alcun tempo dopo, Pinocchio dovette decidere cosa fare da grande e si recò a un corso di orientamento organizzato dall’Università delle Belle Speranze.
Al corso si parlava di come seguire i propri sogni, di come diventare se stessi e realizzarsi.
A proposito dei sogni Pinocchio pensò subito di non averne affatto. L’unico che avesse mai avuto infatti – diventare un bambino vero – si era realizzato grazie alla fatina. Ma non appena con suo padre ebbe aperto l’argomento con più perizia e metodo, i sogni si affastellarono uno su l’altro come funghi su una corteccia umida. E il sogno che aveva al mattino quasi sempre non era lo stesso che lo teneva sveglio la sera.
«Tra medico e avvocato tarabaralla» disse Geppetto, che puntava alla concretezza. «Di’, ti piacerebbe essere medico?»
«Eri tu il mio medico quando ero ancora di legno. Ora che sono di carne, babbino mio, non lo so mica… Cosa fa un medico, tasta o taglia? Temo molto gli spruzzi di sangue e il digrignare delle ossa».
«Le carte allora? I documenti, dico, che vogliono assicurare equità e giustizia… Ti possono interessare?»
«La giustizia è una gran bella cosa, ma in questo paese non sarà forse un lavoraccio? Se mi concentro sulla mia anima riesco però a vedere un tavolo pieno di scartoffie. Da quante ce ne sono non si riesce neppure a vedere chi è seduto dall’altra parte… Mi sembra onesto come sogno. E mi piace far di conto: l’aritmetica e le equazioni sono un vero toccasana per me».
«E sia», disse Geppetto. «Sarai un commercialista».
Così Pinocchio trovò il suo sogno nei rogiti e nei tributi.
39.
Alla scuola per commercialisti Pinocchio conobbe una ragazza e se ne innamorò. Insieme ai dolori e ai mal di pancia dell’amore, scoprì di patire inoltre di una forte discalculia, parola che pronunciò stizzito il professore, un’enorme rana pescatrice con un lumicino che gli ciondolava tremulo dalla fronte.
Era marzo quando ottenne di uscire con la ragazza, che si chiamava Rinuccia e aveva la sindrome dell’orecchio colante, una malattia rarissima che comportò che Pinocchio, con cui Geppetto si era raccomandato di essere il più squisito dei cavalieri, per buona parte dell’appuntamento dovesse tenerle una tazzina sotto il liquido che scendeva a filo, facendo attenzione a sostituirla con un’altra quando stava per spagliare.
Sua madre prima di lei aveva avuto lo stesso problema, gli spiegò, e così la madre della madre.
«Credo che sia impossibile dire “madre” più volte nella stessa frase…» disse sconsolato Pinocchio.
Rinuccia allora lo accarezzò col dorso della mano.
«Mi ami?» gli chiese improvvisamente, e facendolo gli afferrò il naso come i nonni fanno coi nipoti. Pinocchio sentì il cucù nel suo petto accelerare, anche se il tempo, a dirla tutta, era come se fosse rimasto invischiato in quelle parole.
Le orecchie gli fischiarono e la tazzina iniziò a traboccare dell’olio di lei.
«Oh Rinuccia, Rinuccia mia bella, io credo di amarti da sempre, di averti amato prima ancora di essere quello che sono! Credo di amarti da quand’ero ancora di legno… Ma che dico! Da prima ancora di essere un albero! Forse ti amavo già quand’ero solo un pinolo – sì, ora ricordo, ti amo da quand’ero un’animella bianca e dolce nella sua minuscola e polverosa bara di legno… Ecco, credo di amarti perlomeno da allora, prima ancora di cadere nel vuoto e schizzar fuori dalla pigna!»
Di fronte a una tale dichiarazione, Rinuccia fu assalita da una malinconia così struggente (una malinconia di cose che non aveva neppure mai vissuto!) che prese a piangere e a singhiozzare, e Pinocchio cercò con le tazzine che aveva di porre rimedio, ma non faceva in tempo a metterne una sotto l’orecchio che quella dell’occhio destro straripava.
«Che umido le donne!» pensò Pinocchio. «Se è questo l’effetto che faccio, farò bene a portarmi dietro dei sacchi di segatura la prossima volta».
Ma una prossima volta non ci fu perché Rinuccia non si riprese mai da quella sera. Incapace di sopportare tanto amore, finiva le sue giornate nel catino di ghisa per il bagno, stillando linfa come un orniello che, inciso, butta fuori la manna.
40.
Si dice che si diventa davvero adulti solo quando entrambi i genitori sono passati a miglior vita. Nel caso di Pinocchio, alla morte bastò fare metà del suo lavoro presentandosi un’unica volta all’uscio della povera casa per renderlo solo al mondo.
Capitò nei cosiddetti giorni prestati, quelli che stanno come un ponte tra marzo ed aprile, che Geppetto, scivolato già da tempo nella foschia dell’ultima vecchiezza, s’infilasse a letto verso l’una senza neanche aver toccato il pane con i ciccioli che Pinocchio aveva comprato ritornando da scuola.
Per tre giorni e tre notti un figlio vegliò suo padre, una scena tanto lacrimosa da vedere quanto misteriosa da vivere.
All’alba del quarto giorno, mentre i primi raggi di sole penetravano nella stanza buia dalle gelosie delle finestre, un ultimo rantolo strascicato provenne dalla coltre di coperte tarmate e la realtà stessa sembrò cigolare.
Un coniglio nero, prima ancora che Pinocchio sollevasse la testa che teneva fra le mani come una zucca ornamentale, si affacciò dalla porta e, appurato che l’ora fosse giunta, fece cenno agli altri tre di seguirlo e di portare la bara.
Oh quanto dolore e quanta assurdità in quei momenti! Pinocchio non lo avrebbe mai creduto. E dopo aver lasciato la stanza, per la disperazione ritornò poco dopo a perdifiato, perché era il suo babbino quel corpo grinzoso disteso là, e se lo abbracciò un’ultima volta, notando quanto fosse piccolo ormai rispetto al suo, quanto fosse ossuto e secco come un giunco.
«Che senso potrà mai avere tutto questo! Che storia potrà mai raccontarmi la fatina adesso!»
Venne poi la civetta, il dottore, e tastò il defunto come si fa con le camere d’aria delle biciclette per trovare il buco.
«Ancora una volta si è compiuto il mistero» si limitò a dire.
La carriera l’aveva infine reso stringato.
«Restare in silenzio di fronte al mistero è il solo che possiamo fare» concluse.
41.
Sbrigate le cose prosaiche, firmate le fatture e spese le penultime monete per il funerale, Pinocchio se ne andò all’osteria del Gambero Rosso e bevve più che poté.
Quando ne uscì barcollante dopo dieci ore, un ramarro passò di lì con un cesto pieno di minuscole cappellette di fungo.
«Vedo che finalmente vuoi uscire da te stesso, ragazzo mio» gli disse. Pinocchio si distese a terra e vomitò. «O non sei forse già un uomo?»
Così detto il ramarro gli propose una dose da uomo di quei funghi che, a sentir lui, molto meglio del vino e della grappa gli avrebbero donato l’oblio e fatto viaggiare lontano l’anima.
Pinocchio però non aveva più soldi per pagare il ramarro poiché aveva speso le ultime monete per il vino e la grappa. Ragionò come poté, tra il pensiero del babbo e quello di Rinuccia che pure, chissà come, s’era rimesso in mezzo.
«La mia povera casa non è granché – esordì, pulendosi la bocca con la manica – ma per me da solo è di certo troppo grande, e troppo triste, adesso, è tornarci».
Il ramarro assentì come se capisse.
«Se la vuoi, te la do. In cambio però voglio tutto il cesto».
Il ramarro lo guardò dapprima sbalordito, quindi, atteggiandosi da scafato affarista, gonfiò il petto e allungò la sua mano squamosa verso quella puzzolente e bianchiccia di Pinocchio.
«Affare fatto», disse contento.
Poi lasciò cadere il cesto, si fece dare indirizzo e chiavi e se ne andò di corsa.
42.
Pinocchio camminò per delle ore nella notte che scuriva, con il cesto in una mano e niente nell’altra, mentre la natura intorno sprigionava profumi acri e dolciastri da fiori che non poteva vedere e i grilli sfregavano le loro ali coriacee per attirare le femmine.
A un certo punto, uscito dal bosco, entrò in una vasta pianura in fondo alla quale vide un treno merci fermo e silente, illuminato solo dalle stelle. Quando lo raggiunse trovò un vagone aperto e vi si stabilì dentro, in un cantuccio.
Senza pensarci troppo ingollò una manciata di quei funghi perché il pensiero di sé e delle sue miserie aveva ripreso ad angosciarlo.
«Si dia inizio al viaggio» disse, e gli sembrò di sentire uno strattone delle rotaie. Chiuse gli occhi, pensando di avere un’immaginazione troppo fervida, ma uno sferragliare dapprima lieve e poi più sostenuto cominciò di fatto sotto di lui, mentre vedeva le macchie nere della selva cambiare, crescere, sparire e susseguirsi in questo modo.
Il treno era partito e il suo andamento traballante aumentò la disperazione del momento, quella totale mancanza di controllo, e Pinocchio scoppiò in un pianto dirotto.
«Di tutti i bambini veri, di tutte le persone vere, dovevo essere proprio io? Che schifezza essere una persona vera! Che desiderio infausto da esprimere! Ma cosa mi sarà preso! Sii te stesso, ti dicono… Segui i tuoi sogni… Perché non ti danno direttamente una rivoltella? Così è tutto un volere, volere questo, volere quest’altro… Quanti fili ha l’anima mia? Smetterò mai di essere un burattino?»
Dicendo queste parole Pinocchio si avvicinò al bordo del vagone, proteggendosi dal vento che frustava il portellone, e immaginò di gettarsi nel vuoto. Si sporse ancora fino a farsi male agli occhi nell’aria fredda e dura, quando una voce, dall’angolo buio opposto a quello dove stava, disse:
«Volere è dolere».
«Chi parla?» chiese Pinocchio impaurito.
Ma la voce continuò senza rispondere: «Volere è dolere, ma questo non te lo dicono. Non possono farlo. A dirla tutta, non lo sanno neanche loro».
Era una voce ruvida come la carta a vetro che usava Geppetto. E come la carta a vetro era più smerigliata sulle parole sottili, quelle proferite con maggior cura, e più grossa sulle altre meno esatte e più volgari.
Il treno intanto correva tagliando il paesaggio.
«Morire è un desiderio prezioso – riprese la voce – ma bada che c’è morte e morte. Se sei arrivato al punto di voler morire è perché hai percepito l’inganno. Nessuno è libero, finché lo vuole. Nessuno è felice, finché lo vuole».
Pinocchio, rientrato nel vagone, distanziò i piedi cercando di mantenere l’equilibrio e strinse gli occhi per scorgere qualcosa nell’oscurità. Fece un paio di passi verso la voce ma non appena gli parve di averla raggiunta, ecco che la voce raggiunse lui da dietro.
«Non deve essere il dolore, né la mancanza, a guidarti nella morte, ma la comprensione».
Pinocchio ruotò la testa disorientato: ora la voce sembrava provenire da tutti e quattro gli angoli contemporaneamente.
«La comprensione stessa è un olocausto».
Una curva improvvisa schiantò Pinocchio a terra e per poco non venne davvero scagliato fuori. Una prospettiva inedita si aprì alla destra del treno: la luna nuova spiccava come un sorriso sghembo al centro della notte.
«Voglio proporti una sfida, un’indovinello che potrebbe portarti alla fine del tuo viaggio, con una risposta alle tue domande. Se così non sarà, almeno ci saremo divertiti. Dopodiché, se vorrai, potrai tornare alle tue manie suicide. Del resto, la sfida ha a che fare proprio con la morte…»
Pinocchio era così sconvolto da tutto quello che gli era accaduto dopo la morte del babbo – il Gambero Rosso, l’incontro con il ramarro, il treno e infine la voce senza la bocca – che non era riuscito ancora a dire niente.
Assentì tuttavia con la testa.
«Ascolta attentamente allora e non perdere nemmeno una parola: nel diamante nel cuore della città posto, un sarcofago in bella vista è nascosto».
Pinocchio ripeté dentro di sé per non dimenticare: nel diamante nel cuore della città posto, un sarcofago in bella vista è nascosto…
«Ehi, un momento… Ma quale città?» chiese senza più sapere dove rivolgersi.
Ma la voce se n’era ormai andata.
Pinocchio si distese e lentamente si addormentò cullato dal tunturun del treno.
43.
Al risveglio il treno era fermo a una stazione gremita di gente e di rumori. Pinocchio scese col suo cesto e lesse in alto: Stazione di Firenze.
Emozionato di trovarsi per la prima volta nella grande città, si mise in cerca dell’uscita, ma un carabiniere, vedendolo tutto arruffato, gli si parò davanti e gli chiese dove volesse andare. Al che Pinocchio, per una forma di senso di colpa ormai radicata e antica, pensò di scappare immediatamente dalla parte opposta, dove però un altro carabiniere già si stava avvicinando. Allora alzò le mani colpevole, e il carabiniere, perplesso, gli chiese se avesse bisogno di un’aiuto o di sapere una direzione, perché sembrava proprio il tipo di campagnolo che arriva in città e non sa dove andare.
Dopo un secondo di esitazione, in cui Pinocchio rimise giù le mani con discrezione, gli tornò in mente, seppure la sua testa fosse ancora piena di bruma come un’alba invernale, l’indovinello della voce senza la bocca.
«Saprebbe mica indicarmi il diamante nel cuore della città posto?»
«Come dice, scusi?» rispose il carabiniere ancora più perplesso, mentre l’altro faceva un’espressione come dire “ah questi forestieri, tutti uguali, leggono una guida e pensano di saperne più di noi”.
«Ma sì – ripeté Pinocchio – deve esserci un diamante nel cuore della città!»
Ma i due carabinieri lo presero per scemo e si limitarono a indicargli l’uscita e la direzione per la cattedrale che sicuramente, dissero, si trovava al centro della città.
«Prima di andare – aggiunse il primo – mi faccia vedere quel cesto».
Pinocchio a questo punto non poteva certo darsela a gambe, così fece finta di nulla e fischiettando avvicinò il cesto al muso adunco del tutore dell’ordine, che ce lo infilò dentro senza riserve.
«Questi se li fai trifolati sono la fine del mondo. Burro, aglio e nipitella… – e elencando gli ingredienti si fece venire l’acquolina in bocca da solo – Ma non devo insegnarti nulla, vero? Mai visti tanti chiodini così belli…»
Pinocchio sempre più meravigliato balbettò:
«Ah, io pensavo… Dunque sono chiodini?»
«Al cento per cento. Potrò essere anche un vecchio falco di città, ma i funghi li so riconoscere bendato e con le mani in tasca»
A queste parole Pinocchio non esitò più, ringraziò i due carabinieri e si fece strada verso l’uscita.
44.
Arrivò alla cattedrale da una stradina stretta e non da uno stradone come si sarebbe aspettato, cosicché fu colto alla sprovvista quando, uscito dal vicolo, la maestosa facciata invase il suo campo visivo e sbaragliò ogni altra cosa gli stesse intorno. Il cielo stesso sembrò improvvisamente ridimensionarsi e Pinocchio rimase col naso all’insù qualcosa come dieci minuti prima di ritornare in sé, cambiando posa e incrociando le braccia come se reclamasse la parola dopo un lungo monologo dell’interlocutore.
Si allontanò di qualche passo e iniziò a notare le persone che circolavano senza quasi fare caso alle tonnellate di marmo impilato fino alle nuvole.
Tanta bellezza suscitò in Pinocchio un’emozione paradossale e nuova, a metà fra un’intimità più profonda ancora di quella provata da solo nella sua cameretta e uno sconfinato distacco dalle cose.
Quando suonarono le undici decise di salire sul campanile a mo’ di vedetta. Contò 398 scalini e l’affaccio, una volta in cima, era spettacolare. Vedeva la città allungarsi da ogni lato e le colline intorno cingere gelosamente la valle. Ma sotto, proprio sotto di lui, una punta ottagonale bianca e rilucente come schiuma del mare catalizzò la sua attenzione. Subito si scapicollò giù e vide al centro della piazza una struttura composta e geometrica, ornata di linee, rettangoli e poco altro se non l’idea stessa di sobrietà che ne emanava.
Eclissato dalla cattedrale, all’inizio non l’aveva neppure visto.
«Ora che ho trovato il diamante nel cuore della città posto – esclamò – non mi resta che cercare il sarcofago in bella vista nascosto!»
Fece allora il giro di quell’ottagono scrutando con attenzione dettagli e finiture. C’era una porta d’oro dove si raccontava una storia, c’erano delle statue e delle finestrelle. Ma del sarcofago neanche l’ombra. Fece ancora il giro e ancora più attentamente guardava, e guardava, e guardava, ma niente… Finché, stremato, si accasciò su di un lato, e sentì una sporgenza puntargli la schiena.
Si era appoggiato alla parete credendola liscia, poiché tutto l’edificio era liscio e preciso come una gemma intagliata. Cosa poteva essere quindi? Si girò e vide che alla base dell’ottagono, proprio dove si era seduto – una zona che in effetti non aveva battuto con la dovuta attenzione – c’era un bassorilievo scolpito nel marmo.
Era l’unico blocco scolpito di tutto l’edificio e era più giallino degli altri, come il pezzo sbagliato di un puzzle, come quando Geppetto metteva una gamba di ciliegio a un tavolo d’olivo.
«Che strano – pensò Pinocchio – che sia questo il sarcofago?»
A quel punto un venticello lieve cominciò a spirare e insieme a lui arrivò lontana come un eco una voce:
«Bravissimo Pinocchio, sei riuscito nel primo indovinello».
Subito Pinocchio drizzò la testa, guardandosi attorno circospetto, intanto che quel timbro ruvido come la carta a vetro si faceva strada nella sua memoria.
«È la voce senza la bocca!» urlò poi sollevato e sorpreso di esserlo a tal punto. «Che strano sentirti fuori dal treno e alla luce del sole, vocina! Che stranissima giornata!»
«Convengo con te, Pinocchio – continuò la voce senza la bocca –: questa sarà per te la giornata più strana».
Detto ciò la brezza divenne un sibilo sottile come la tela di un ragno e la voce disse:
«Risolvi questo secondo e ultimo indovinello e tutti i fili invisibili che ancora ti avvincono saranno d’improvviso tagliati. Devi comprendere il significato del sarcofago, esso solo custodisce la verità. Ascolta attentamente allora e non perdere nemmeno una parola: calpestata risorge».
Aspettandosi altre parole Pinocchio non disse o chiese nulla, finché il sibilo non cessò e con esso la speranza di ottenere ulteriori chiarimenti.
«Certo – pensò Pinocchio – questa volta non c’è molto da ricordare… Due parole soltanto: Calpestata risorge. A cosa si riferirà la voce? Quale sarà il significato del sarcofago?»
Seduto nel punto in cui la scarsella usciva dal lato dell’ottagono, Pinocchio si mise a gambe incrociate a fissare il bassorilievo.
C’erano due scene: nella prima una nave con le vele ancora piegate attendeva forse di partire, e nell’altra due uomini affondavano le gambe dentro qualcosa che non si riusciva a distinguere perché il bassorilievo era molto consumato dal tempo.
Guardò le due scene per ore, ripensando alle parole della voce senza la bocca e ripetendole fino a che non persero il loro significato.
Calpestata risorge…
L’intera giornata passò in questo modo, né Pinocchio pensò di mangiare o andare in bagno.
Quando il sole terminò la sua parabola e l’ombra raggiunse Pinocchio nel suo angolino, una fredda disperazione lo avvolse come una coperta.
Due lacrime striminzite si fecero strada agli angoli degli occhi. Come il pesce preso all’amo srotola tutta la lenza, così l’idea di fallire l’ultimo indovinello portò con sé tutte le convinzioni maturate da Pinocchio.
«Chi sono io?» sussurrò con la testa fra le gambe.
«Sono il figlio di un povero falegname, passato indenne da tutte le sue scapestrate peripezie fino a capire e a convincermi della bontà d’animo e della generosità? Sono un aspirante commercialista, amante del far di conti? Perché è così che me la racconto… O sono forse il cuore spezzato e illuso, innamorato di una ragazza dall’anima straripante e zampillante? Sono tante cose, tanti fili tesi. E tirano tanto e in tante direzioni che non riesco più a muovermi. Resto immobile, allora, sospeso a mezz’aria».
Con rinnovata meraviglia si guardò il palmo della mano e le linee rosa che lo attraversavano, diramandosi in mezzo alla pelle complessa e labirintica. Era forse lì dentro il segreto?
«Fatina, ho bisogno ancora del tuo aiuto e della tua magia! Vorrei essere la fortezza e la torre che mi dicesti, ma semplicemente dubito e crollo dalle fondamenta…»
In seguito a questa disperata invocazione gli tornarono in mente tutta una serie di buoni consigli.
Sii te stesso.
Segui il tuo cuore.
Realizza i tuoi sogni.
Per un attimo la fatina gli comparì davanti, quindi scomparve per riapparire qualche secondo dopo quando più si concentrava sui buoni consigli. Pinocchio trabalzava dalla speranza alla disperazione, intanto che la fatina appariva e scompariva a intermittenza, come una lucciola nella notte.
«Ma sì – pensava – sono forte come una fortezza e alto come una torre! Sono le cose che ho imparato, sono la mia ambizione, sono i sentimenti che provo per Rinuccia e Rinuccia sarà mia, perché mia è da sempre! E sarò un grande commercialista, il miglior commercialista del mondo! Rogiti, dichiarazioni, fatture! Tutti sapranno il mio nome e mi guarderanno con ammirazione e di questa ammirazione farò frecce per il mio arco e coccodrilli per il mio fossato, farò malta e mattoni per le mie immense mura!»
La fatina crebbe ancora in luce e consistenza mentre Pinocchio si rialzava e piantava simbolicamente i piedi a terra.
Calpestata risorge…
Con la coda dell’occhio guardò un’ultima volta il bassorilievo sul sarcofago incastonato nell’ottagono. La foglia che stava fra i due uomini l’aveva vista milioni di volte nei campi intorno a casa. E il ramo da cui pendeva… Ma certo! Perché non ci aveva pensato prima: era il tralcio d’una vite! E quello in cui gli uomini affondavano i piedi era ovviamente una grande catino pieno d’uva!
«Calpestata risorge» disse Pinocchio. E capì.
La sua voce si era arrochita nell’umido della notte e nella brezza che aveva ripreso a soffiare.
«L’anima è come l’uva. Se la calpesti, se la rendi poltiglia, risorge come vino, cioè come spirito».
La fatina davanti a lui si fece trasparente e Pinocchio poté vederle attraverso. Come in traslucido vide dietro di lei un’altra donna che al posto della bacchetta teneva una scopa con cui spazzava l’adito di casa. Non aveva i capelli turchini ma neri come i suoi e legati dietro con una grazia che lo commosse.
Ma anche l’altra donna divenne presto traslucida e poté vederle attraverso. Dietro ancora, dietro alla fatina e all’altra donna, vide un uomo senza capelli, con delle folte sopracciglia spioventi e una buffa barbetta bianca, che scriveva chino e instancabile sulla tavola invasa da pile di fogli già scritti e fogli da scrivere.
Quindi Pinocchio, con voce sempre più sicura, quasi non sua, aggiunse: «La vera magia è l’illusione di sé. Il mio mondo è un mondo di fiabe. L’io non esiste, tutto il resto è la realtà».
Dette queste parole, i tre piani trasparenti svanirono lasciando spazio al cielo stellato.
Pinocchio fece qualche passo e di colpo, con un rumore possente ma felpato, il suo corpo venne avviluppato da mille fiammelle bianche che ardevano senza bruciarlo.
Nella foresta, intanto, una pigna cadde dal pino e un pinolo ne schizzò fuori.